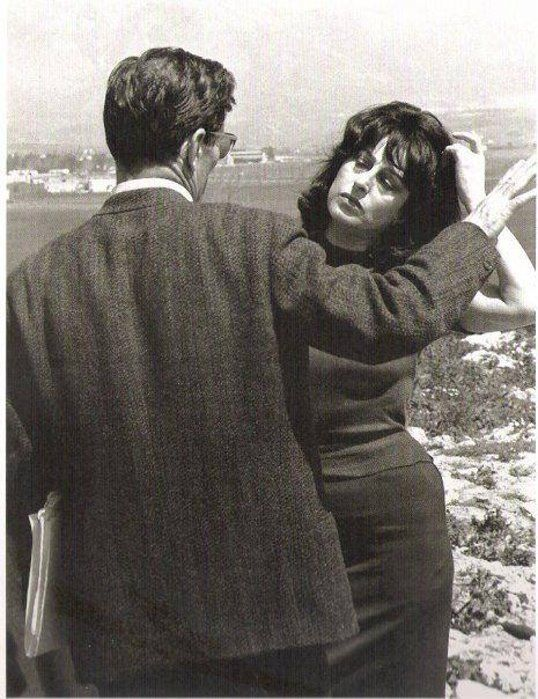L’ex imbianchino Sergio Citti già dalla metà degli anni ’50 aveva casualmente cominciato a collaborare con Pier Paolo Pasolini, prima come dizionario romanesco vivente per i suoi romanzi di ambientazione romana “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, poi come sceneggiatore e aiuto regista, finché nel 1970 compie il gran salto e si mette in proprio, si fa per dire, e debutta come regista con un film che riprende le tematiche dei primi film di Pasolini: l’autore friulano è passato oltre e adesso lavora al suo nuovo progetto che sarà chiamato trilogia della vita e che sarà improntato a un erotismo esplicito: “Il Decameron” “I racconti di Canterbury” e “Il fiore delle Mille e una Notte”. Qui soggetto e sceneggiatura sono di entrambi ma come leggiamo subito nei titoli di testa “Pier Paolo Pasolini presenta” e infine, dopo la voce regia che in genere è l’ultima, leggiamo ancora “supervisione tecnica e artistica di P.P.P.” che da un lato vuole rassicurare lo spettatore dato che ormai Pasolini è ufficialmente anche un autore cinematografico di tutto rispetto, e dall’altro è una sorta di imprimatur e viatico al suo delfino che si sta buttando nel mare degli squali.
Alla produzione e distribuzione due nomi secondari dell’ambiente: il direttore della fotografia Alvaro Mancori, che si è anche cimentato come regista in due soli film, e Anna Maria Chrietien che aveva provato a fare la costumista nel peplum “Ercole l’invincibile” del 1964 diretto dallo stesso Mancori, e che poi entrerà nella produzione di altri due film prima di scomparire dal mondo cinematografico: evidentemente la liaison con Mancori si era conclusa; se ne deduce, ed è evidente, che il film è realizzato in assoluto risparmio, ma questo diventa un pregio se a muovere l’intero apparato c’è un regista che sa quello che fa, e il debuttante Sergio Citti, benché supervisionato dal suo maestro, lo è.
Anche la coppia dei protagonisti è assolutamente in linea: Franco Citti, fratello di Sergio, che Pasolini aveva voluto come debuttante “Accattone” nel suo debutto da regista, e il francese già apprezzato il patria Laurent Terzieff che era approdato a Cinecittà nel 1959 con “La notte brava” di Mauro Bolognini sceneggiato da Pasolini da un suo racconto; e poi sempre Pasolini lo aveva diretto dieci anni dopo nella sua “Medea”, dove gli aveva affidato il ruolo del centauro Chirone; quindi possiamo dire che al momento l’attore francese era di casa nell’entourage pasoliniano e sembra naturale che sia entrato da protagonista e primo nome in cartellone nel cast del debuttante Sergio Citti; forse anche con l’intento di riuscire a vendere il film oltralpe dove Pasolini era molto amato. I due protagonisti funzionano bene come fratelli borgatari ladruncoli e sedicenti anarchici come il padre ubriacone, ma non ferventi cattolici come era la madre che, significativamente, è finita al manicomio dove il film comincia: la religione non salva l’anima e piuttosto la corrompe – più pasoliniano di così! Il vero borgataro Citti e l’aristocratico attore teatrale francese Terzieff, a discapito dell’enorme differenza che intercorre fra loro, funzionano bene come coppia di fratelli disfunzionale; il primo perché è assolutamente se stesso nel personaggio che gli ha scritto il fratello, senza i tragici tormenti esistenziali, di derivazione borghese, che il borghese Pasolini immetteva nel mondo dei sottoproletari come lui li vedeva e raccontava; e Franco diretto da Sergio acquista una credibilità che a mio avviso non aveva ancora espresso sotto la direzione del maestro. Laurent Terzieff si mimetizza nel personaggio lontanissimo dalla sua natura proprio perché attore di razza, e la sua faccia scavata e non immediatamente bella lo aiuta a diventare un delinquente ignorante senza tormenti esistenziali, o meglio: con dei tormenti che nel racconto di Citti rimangono puro stato magmatico perché in quel mondo non si conoscono le parole e i processi di auto analisi per esprimerli.
Esemplare la scena in cui Rabbino – è il soprannome del personaggio di Citti in un mondo in cui i soprannomi assurgono a nomi propri – ricorda a Bandiera quella volta in cui da ragazzi, dopo aver fatto i guardoni spiando un vecchio che scopava con una mignotta, si sono baciati sulla bocca e fatto insieme le zozzerie come se fossero stati due fidanzati; e Bandiera non ricorda o non vuole ricordare: noi borghesi intellettuali diremmo rimuove. Scena cardine che all’epoca la critica ha messo al centro della discussione individuando nei due protagonisti una latente omosessualità – senza peraltro parlare dell’incesto fraterno perché essendo gioco fra maschi non c’è rischio di procreazione, che è il tabù principale. A mio avviso l’omosessualità raccontata da Citti è fittizia perché coatta, espressione di necessità contingente, del far di necessità virtù, mancanza di migliori opportunità; omosessualità di ripiego quando – tanto per restare romaneschi – non c’è trippa per gatti, la stessa omosessualità che talvolta si esprime nei luoghi chiusi a lungo corso come le carceri, le navi di una volta, i collegi degli adolescenti, le caserme delle reclute: sfogo di naturali istinti all’accoppiamento che si rivolge al simile in mancanza del diverso, esplosione di testosterone, sperimentazioni sul proprio corpo – anche fra femmine – che però non necessariamente conducono all’omosessualità conclamata e da lì in poi praticata: finita l’emergenza della cattività si torna ai rapporti reali. E di fatto nei due fratelli raccontati da Sergio attraverso suo fratello Franco e il francese cui lui stesso dà la voce al doppiaggio, guarda un po’, non c’è desiderio di natura omosessuale, tutt’altro: diventano rivali quando nella loro vita irrompe una bionda esplosiva; anche il gioco del travestimento con le parrucche, cui la donna li sottopone, benché spinga il nostro giudizio nel verso dell’omosessualità, rimane un’altra divertente sperimentazione: è una posizione ambigua, ancorché coraggiosa, quella del nuovo autore cinematografico che successivamente nelle sue sceneggiature e regie tornerà sull’argomento, come in cerca di pacificazione con un argomento spinoso: esemplare sarà il suo ultimo film “Fratella e sorello”, film oggi riconosciuto di interesse nazionale ma clamoroso fiasco al botteghino.
Meno riuscita, anzi non riuscita affatto – e non ci è dato sapere chi l’abbia doppiata – è l’introduzione nel cast della svedese Anita Sanders, modella molto a suo agio col nudo – poserà diverse volte per Playmen – e nel film ce ne dà ampie dimostrazioni; è scesa in Italia per cercare di bissare il successo di un’altra Anita sua conterranea, quell’Anita Ekberg che in Federico Fellini troverà un pigmalione, il quale però riserverà a quest’Anita numero due solo un piccolo ruolo in topless in “Giulietta degli spiriti”; e ricordiamo che in quegli anni approdò da noi un’altra Anita svedese, Anita Strindberg, che spopolò nei nostri thriller-sexy: il mediterraneo nome Anita era all’epoca molto in voga nelle terre del nord. Anita Sanders, che qui interpreta una di quelle borgatare mignotte per diletto come si sono già viste in altri film d’impronta pasoliniana, è troppo bionda e troppo ben truccata con quegli occhioni da fotomodella in un epoca in cui purtroppo al cinema le belle donne erano sempre ben truccate anche se il personaggio e il contesto non lo richiedevano: che fossero appena alzate dal letto o uscite dalle onde del mare il make-up era sempre perfetto; e la svedesona è troppo nordica e ammaliatrice per essere credibile in una cruda vicenda di borgate. Pasolini la utilizzerà due anni dopo in “I Racconti di Canterbury” e il suo ultimo film sarà “Quell’età maliziosa” del 1975 dove a soli 33 anni interpreta la madre di Gloria Guida che ne ha 20 e allora decide di chiudere lì con la recitazione; nel 1977 fa da assistente alla regia a Sergio Citti sul set di “Casotto” probabilmente solo per metterla a foglio paga e aiutarla a sopravvivere. Importante il commento musicale di Francesco De Masi, compositore attivissimo negli spaghetti-western con talmente tante produzioni all’attivo da essere annoverato tra i nostri più significativi compositori perché ha anche avuto il talento, e il gusto, di non scopiazzare il maestro del momento Ennio Morricone ma di portare avanti uno stile suo personale.
Nel resto del cast, oltre al solito manipolo di veri borgatari attori per caso che non si avvieranno a una carriera professionistica, tornano Ninetto Davoli e l’ex protagonista di “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica che da romano verace si è in quel periodo riciclato con piccoli ruoli nel cinema pasoliniano: Lamberto Maggiorani, come padre della bionda. Altri professionisti sono Gianni Pulone come prete che tenta di confessare i due fratelli al gabbio, e al suo debutto cinematografico la teatrale, poi anche professionista del doppiaggio, Lily Tirinnanzi qui ancora accreditata come Luisa, nel ruolo della madre dei due, e che probabilmente è anche la voce della Sanders.
Il film di debutto di Sergio Citti è dunque un’operina che, pur risentendo dell’ispirazione del maestro, già viaggia su una strada tutta sua introducendo un gusto per il grottesco e il surreale che sembra mediato dal teatro dell’assurdo di un Samuel Beckett e del suo “Aspettando Godot” dove due individui, come i nostri due fratelli, compiono sempre le stesse azioni: Bandiera e Rabbino vivono una vita senza senso dove il senso è proprio quella mancanza di significato, esistenze senza dio e intrise di un’ideologia anarchica solo copiata da un padre pessimo esempio di autorità maschile e, come a teatro, entrambi in attesa che qualcosa accada, e accade quando fra loro s’introduce l’aliena bionda. E Citti sceglie una narrazione altrettanto alienata dove le scene e le sequenze si rincorrono anche senza uno sviluppo logico e con risvolti improvvisi e surreali, come quando la donna comincia improvvisamente a suonare una fisarmonica e i due fratelli si mettono a ballare il tango. E c’è nel film quella verità che è sempre mancata al friulano Pasolini che si è fatto romano per passione dei borgatari romani che ha raccontato dal suo privilegiato punto di vista, sempre borghese ahilui, e secondo le sue necessità narrative socio-filosofiche; Sergio Citti è un vero borgataro romano e la sua verità, che racconta con leggerezza una favola turpe, è sincera e tragicamente disarmante perché lascia intuire sprazzi di autobiografia i cui dettagli non sapremo mai.