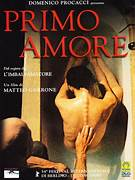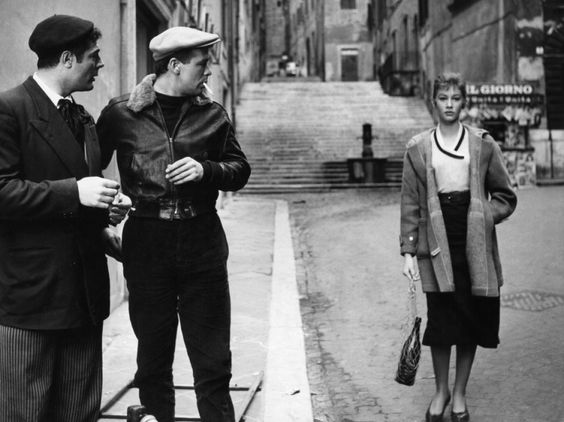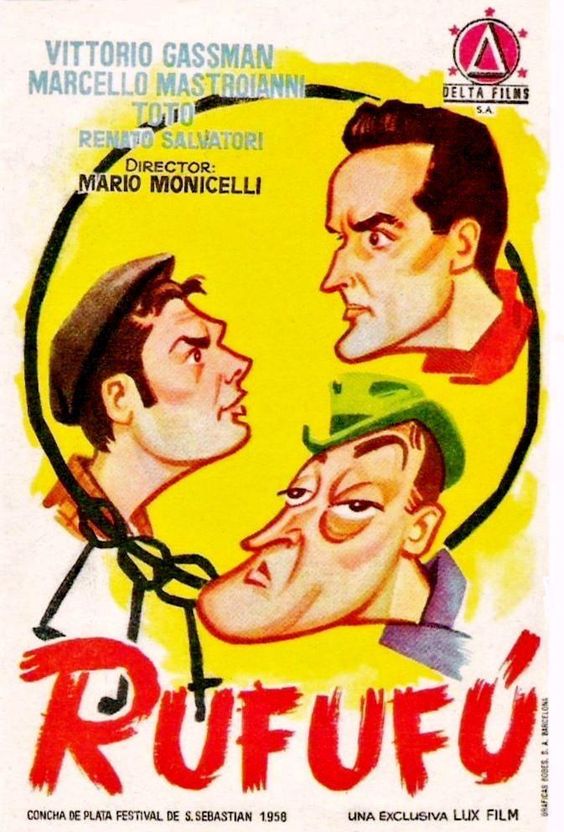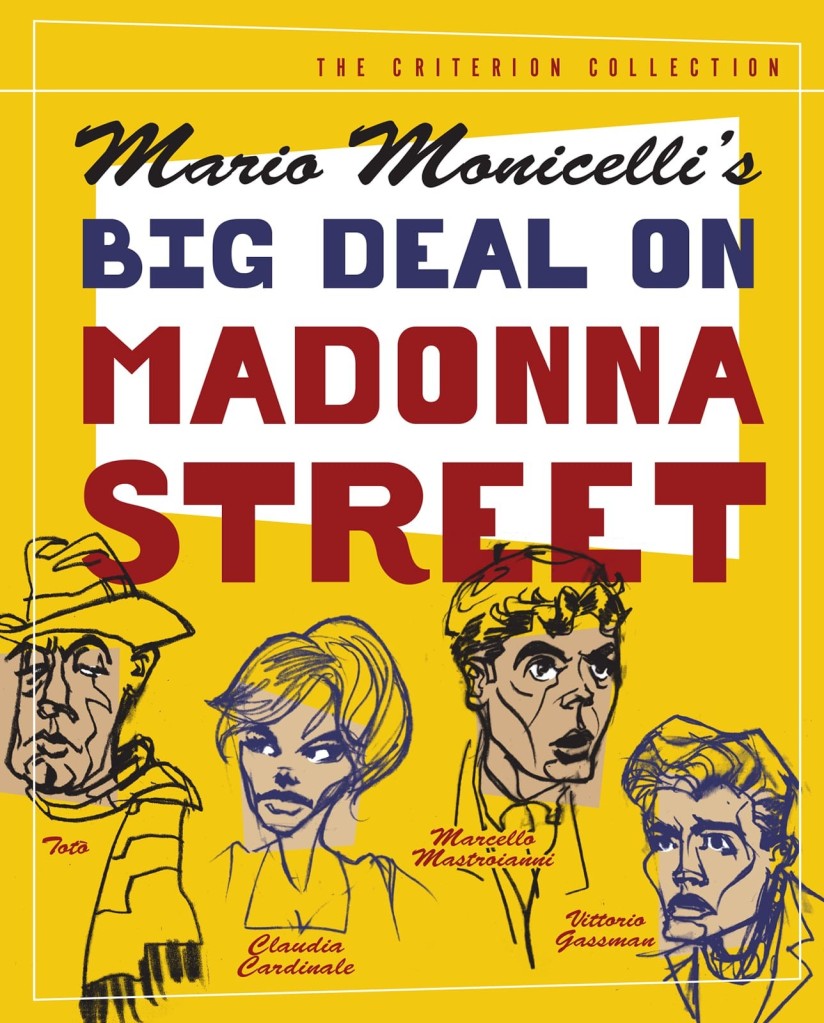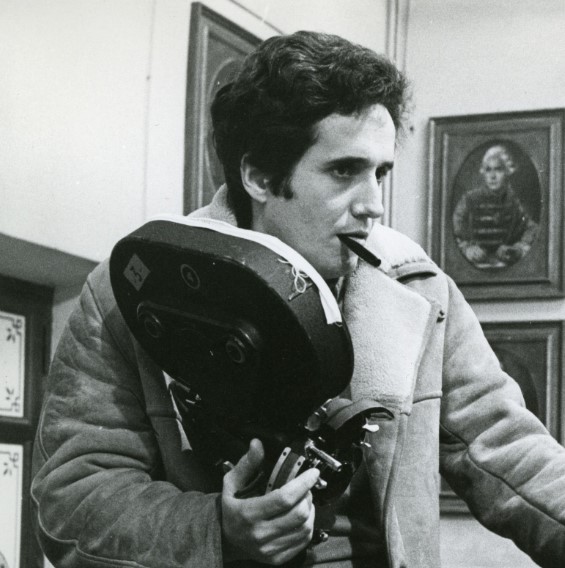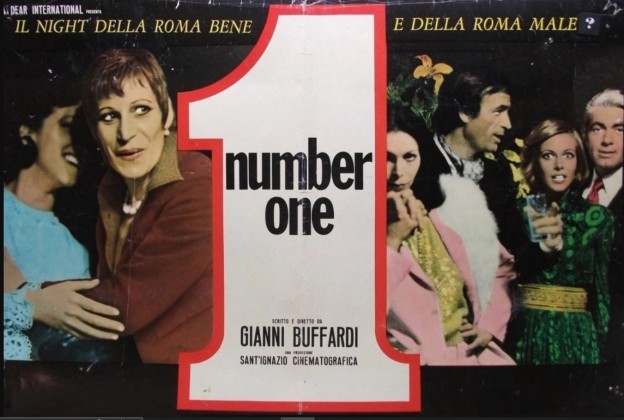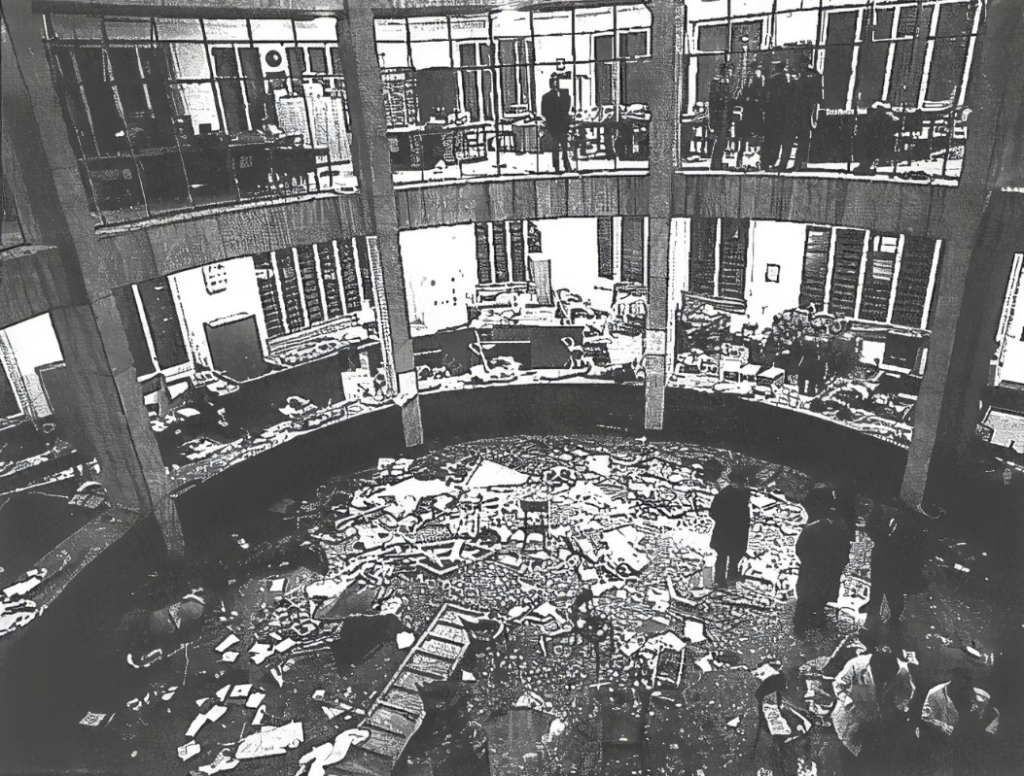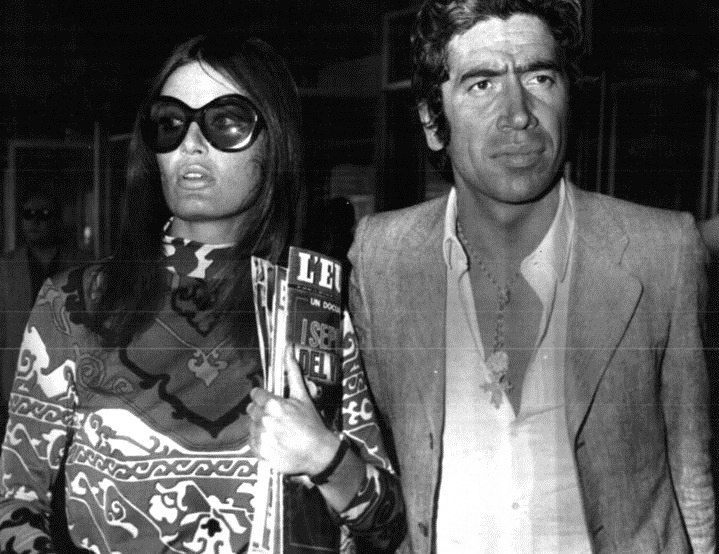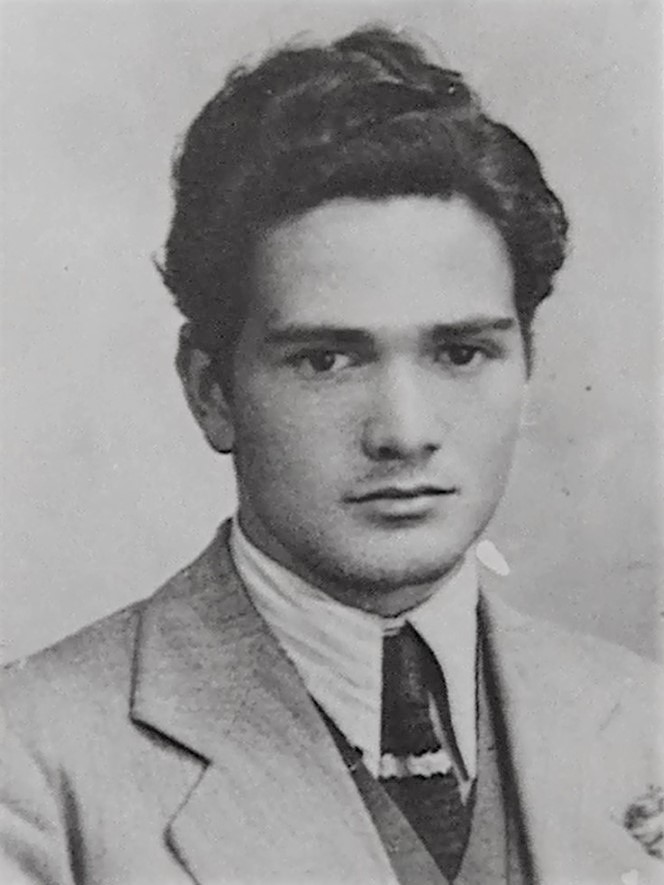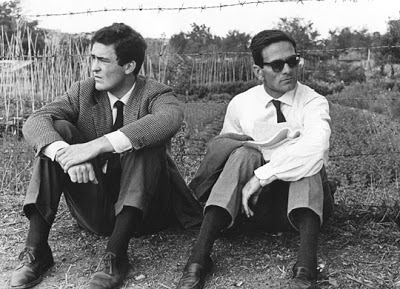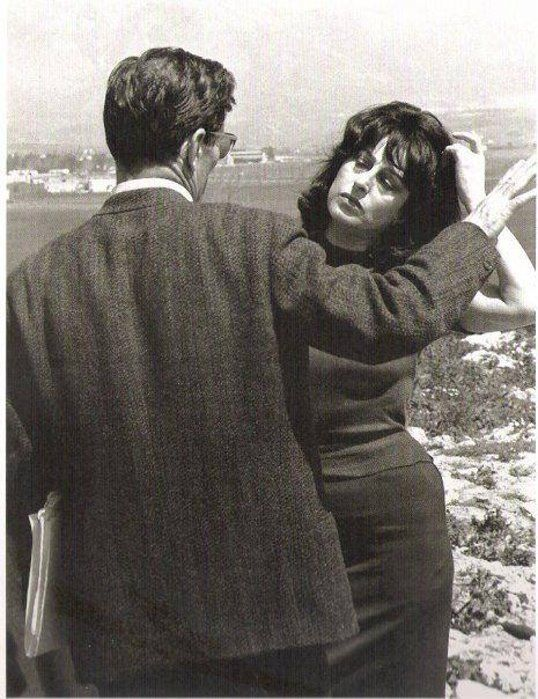Matteo Garrone non ce l’ha fatta agli Oscar 2024, come non ce l’ha fatta ai Golden Globe dove era altrettanto candidato, e a mio avviso non poteva farcela perché la concorrenza al Miglior Film Internazionale (ex Miglior Film Straniero) era di altissima qualità, nulla togliendo all’italiano. L’Italia, che in ogni caso mantiene il più alto numero di candidature in quella sezione, mancava esattamente da dieci anni quando nel 2014 fu presente con “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino che si portò a casa la statuetta insieme al Golden Globe: Sorrentino come nemesi di Garrone? andiamo con ordine.
I due astri nascenti, diversissimi, si ritrovano a confronto in quel di Cannes nel 2008, Garrone con “Gomorra” dal libro inchiesta Roberto Saviano che poi ha moltiplicato pani pesci puntate e pubblico con le 5 stagioni della serie tv Sky, e Sorrentino con “Il Divo” sul mefistofelico Giulio Andreotti; entrambi erano in concorso per la Palma d’Oro che però restò in casa andando a Laurent Cantet per “La classe – Entre le murs” ma i nostri vennero premiati con le pergamene del Grand Prix Speciale della Giuria (quell’anno presieduta da Sean Penn con Sergio Castellitto come italiano fra i giurati) a “Gomorra” e il Premio della Giuria per “Il Divo”, tenendo presente che i due riconoscimenti sono lo stesso premio con due diverse diciture ed è il più importante dopo la Palma d’Oro: insomma due premi apparentemente diversi per non assegnare un ex-aequo. Da lì in poi la stampa ha inventato, o chissà forse solo registrato, una concorrenza diretta fra i due – che non analizzerò per non dilungarmi come al mio solito.
Tornando a oggi, qualsiasi sia la concorrenza vera o presunta fra i due (per certo non sono amici), entrambi sono assai stilosi e di Matteo Garrone si può certo affermare che il tema sociale, insieme al tema del magico e del favoloso, sia parte integrante del suo cinema, con radici coltissime nel favolistico di casa nostra o comunque europeo in generale, e dunque quanto di più lontano dal fumettistico fantastico ed effettistico statunitense: cosa, questa, che lo allontana dal pubblico d’oltreoceano più abituato agli effetti speciali e ai trucchi prostetici che alle atmosfere conturbanti e noir della nostra narrativa fantastica.
Partito ai suoi esordi con stile e contenuti decisamente neo-realistici si fa notare da critica e pubblico con “L’imbalsamatore” (2002) che gli valse il David di Donatello per la sceneggiatura, ma il film collezionò molti altri premi fra attori e produzione: già in questo film usa per il ruolo del protagonista l’attore nano Ernesto Mahieux come elemento di collegamento alla sua visione fantastica della narrativa cinematografica.
Anche il successivo assai disturbante “Primo amore” (2004) liberamente ispirato al romanzo “Il cacciatore di anoressiche” di Marco Mariolini è una favola nera dove l’orco è uno psicopatico ossessionato dalle donne magrissime che spinge la protagonista alla fame in una relazione di amore malato. Segue il “Gomorra” del successo internazionale e dopo realizza “Reality” (2012) dove il protagonista si fa accecare dalle favole moderne e ingannatrici dei reality show, un film con cui torna all’indagine sociale e in cui scatena visivamente la sua vena surreale e grottesca.
Arriva il raffinatissimo, e per questo anche poco digeribile e poco digerito dal grande pubblico, “Il racconto dei racconti” (2015) che schierando un cast internazionale in una coproduzione con Francia e Regno Unito (per cui Garrone anche produttore ha messo un’ipoteca sulla sua casa) è stato distribuito anche col titolo “Tale of Tales”, dalla raccolta di fiabe seicentesche “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile; il film si concentra su tre racconti la cui narrazione si incrocia e incastra, e nell’insieme è un materiale enorme che potrebbe essere raccontato meglio in una coraggiosa produzione televisiva se solo Garrone si lasciasse tentare dalla serialità, cosa che ha fatto Sorrentino in Sky con “The Young Pope” e “The New Pope”, così tanto per dire. Il film di due ore e un quarto lascia un retrogusto amaro in bocca: quello del non perfettamente riuscito – ma la visione fantastica di Matteo Garrone è al suo fulgore massimo.
Ancora con i debiti da pagare accantona il suo successivo grandioso film su Pinocchio e rispolvera un vecchio progetto più a basso costo (4 milioni di euro contro i 15 del precedente) col quale torna alle sue origini di noir metropolitano di indagine sociale: “Dogman” (2018) su un fatto di cronaca nera romana che ebbe come protagonista un uomo detto “er canaro”, altra figura da favola horror, ed è di nuovo amore col Festival di Cannes che premia il protagonista Marcello Fonte, e trionfa ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello, fra gli altri premi. E qui vale la pena spendere una curiosità: all’epoca della prima stesura di una decina d’anni prima, Garrone aveva proposto il ruolo a Roberto Benigni che poi sarà Geppetto nel successivo “Pinocchio”, grande favola che stavolta piacerà anche agli americani, molti dei quali ancora credono che il burattino sia un’invenzione di Walt Disney, e difatti riceve due candidature tecniche per costumi e trucco agli Oscar.
È evidente che Garrone, concorrenza o no, punta all’Oscar; del resto ha già trionfato in casa e in Europa e impugnare quella statuetta lo farebbe assurgere all’empireo ultimo, e qui film torna alle origini della sua ispirazione narrativa. Aveva debuttato nel 1996 con “Terra di mezzo” dove ha raccontato in tre e episodi la realtà di differenti immigrati in Italia, opera prima che al Torino Film Festival gli sono valsi il Premi Speciali della Giuria e il Premio Cipputi per il miglior film sul mondo del lavoro, premio ispirato al personaggio del metalmeccanico comunista creato da Altan; e col successivo “Ospiti” si concentra sulla figura di due ragazzi albanesi immigrati a Roma; dunque il tema dell’immigrazione lo appassiona e con quello che continua a succedere nel Mediterraneo era solo questione di tempo prima che anche Garrone ne traesse ispirazione, avendo già due titoli in una filmografia che è già un genere nella cinematografia italiana ricchissima di titoli a partire dalla fine degli anni ’80 con “Il tempo dei gitani” (1988) di Emir Kusturica cui segue a tambur battente “Pummarò” (1990) di Michele Placido, per dire solo i titoli più importanti, cui seguono “Lamerica” (1994) di Gianni Amelio, “Vesna va veloce” (1996) di Carlo Mazzacurati, “La ballata dei lavavetri” di Peter Del Monte e “L’assedio” di Bernardo Bertolucci, entrambi del 1998 e fra i titoli che si fanno assai più numerosi nel nuovo millennio ricordiamo “Quando sei nato non puoi più nasconderti” di Marco Tullio Giordana, “Bianco e nero” di Cristina Comencini, “Terraferma” di Emanuele Crialese, “Alì ha gli occhi azzurri” di Claudio Giovannesi ispirato agli scritti di Pier Paolo Pasolini, “Razzabastarda” opera prima di Alessandro Gassmann, “Fuocoammmare” di Gianfranco Rosi e il recentissimo “Nour” del 2020 di Maurizio Zaccaro.
I film fin qui realizzati si fermano a raccontare l’incontro-scontro degli immigrati con la realtà italiana e solo in pochi casi raccontano la tragicità del mare attraversato e dei viaggi, mentre Garrone – col suo team di co-sceneggiatori composto da Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e dall’attore Massimo Ceccherini che avendo nel curriculum uno suo spettacolo teatrale su Pinocchio già aveva affiancato come sceneggiatore Garrone nel di lui “Pinocchio” dove anche interpretò la Volpe – va oltre, sbarca in Africa, si addentra oltre il deserto per giungere in Senegal, nei villaggi e nelle case dove una certa politica vorrebbe rispedire i migranti.
Il soggetto di Garrone si ispira direttamente alle storie vere raccontate da Fofana Amara, Mamadou Kouassi Pli Adama, Arnaud Zohin, Brhane Tareka e Siaka Doumbia, tutti ragazzi che hanno realmente compiuto il viaggio dei due protagonisti del film, accreditati nei titoli come collaboratori alla sceneggiatura insieme a Chiara Leonardi e Nicola Di Robilant.
Il casting venne fatto in loco sotto la direzione del camerunense Henri-Didier Njikam che è incorso in un incidente diplomatico allorché gli fu negato dall’Ambasciata d’Italia a Rabat, Marocco, il visto d’ingresso in Italia per presenziare al Festival di Venezia; tempestivamente intervistato da “The Hollywood Reporter Roma”, Njikam ha accusato i responsabili di razzismo: “L’ambasciata ha giustificato il rifiuto sostenendo che non c’erano garanzie che avrei abbandonato il territorio italiano una volta entrato a Venezia. In pratica mi hanno trattato come un migrante, come se volessi approfittare della situazione per scappare. Ma io ho un lavoro, una tessera professionale del Centro Marocchino del Cinema. E, sinceramente, se avessi voluto lavorare in Europa, lo avrei già fatto: l’ente non ha guardato il mio curriculum né i miei documenti, ma solo il colore della mia pelle. Questo problema esiste solo con l’ambasciata italiana in Marocco, perché i miei colleghi dal Ghana e dalla Costa d’Avorio sono riusciti a partire. Se fossi stato bianco, non credo che sarei stato trattato così.”
Seydou Sarr insieme a Moustapha Fall sono i due ragazzi che abbagliati da sogni di notorietà e ricchezza lasciano la certezza di una tranquilla miseria quotidiana per l’incertissimo viaggio dispensatore di sofferenze e morte che tutti sconsigliavano; e Seydou, vero protagonista del film, è stato insignito a Venezia del Premio Marcello Mastroianni come attore emergente, ma l’intero cast è di altissimo livello e tutte le interpretazioni concorrono all’intensità narrativa del film costruito da Garrone senza sbavature e senza retorica, sempre focalizzato sulla tragedia umana di ragazzi che sognano un mondo migliore ma che trovano squali anche nelle sabbie del deserto.
Gli unici fugaci momenti in cui si indebolisce il racconto, a mio avviso, sono le due sequenza oniriche del protagonista che sogna, prima di salvare una donna nel deserto e poi volare indietro fino a casa ad osservare sua madre che dorme: due brevi momenti di abbagliante bellezza cinematografica che proseguono nella linea stilistica dell’autore ma che in questo caso deviano dall’intensità tragica del racconto, intensità universalmente riconosciuta da critica e pubblico.
Le curiosità: 1. resterà negli annali l’imbarazzante ultim’ora del Televideo Rai in cui il film veniva raccontato come la vicenda del capitano Schettino che abbandonò il comando della Costa Concordia incagliatasi sugli scogli dell’Isola del Giglio in Toscana nel 2012. Non si sa com’è andato l’incidente telematico, c’è chi parla di uno scherzo certo per minimizzare, c’è chi parla di un complotto certo per massimizzare, ma l’ipotesi più credibile è quella dell’intelligenza artificiale che ha creato la notizia pescando nel suo database, notizia farlocca che però è stata pubblicata da qualche intelligenza naturale… naturalmente a riposo.
2. le ultimissime di cronaca riferiscono di Claudio Ceccherini che ospite del programma Rai “Da noi a ruota libera” certo ispirato dal titolo ha parlato a ruota libera: “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre.” Va da sé che l’attore sceneggiatore non ha tutti i torti, solo che poteva esprimersi in modo diverso: i membri dell’Academy sono da sempre molto sensibili ai temi della Shoah tant’è che nel 1999 premiò “La vita è bella” di Roberto Benigni, miglior film straniero, miglior protagonista e miglior musica a Nicola Piovani. Non si parla di corde in casa dell’impiccato, si tratta di buon senso ed educazione, e tanto più vanno ponderate le parole in questo periodo di feroce conflitto in Medio Oriente.
3. mia personale curiosità: leggo nella scheda tecnica del film i nomi dei doppiatori ma “Io capitano” è stato distribuito in originale, il wolof parlato in Senegal, il francese e l’inglese, e non c’è traccia di doppiaggio. Si tratta forse di un’altra versione che sarà distribuita nelle versioni Home e On demand?
Accantonata la delusione per non avere afferrato la statuetta dorata Matteo Garrone guarda già al futuro per il suo bellissimo film che proseguirà il viaggio tornando nei luoghi da cui è partito, con proiezioni nei villaggi del Senegal anche su tendoni improvvisati, per raccontare a chi resta che a volte è più coraggioso restare. Meglio che morire nel deserto o nel mare, meglio ancora che essere umiliati da società e apparati politici ciechi alle urgenze umane nel coltivare i loro minimi miserevoli giardinetti recintati e vietati agli estranei.