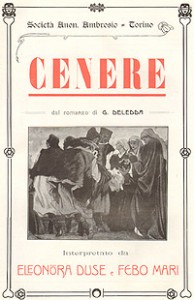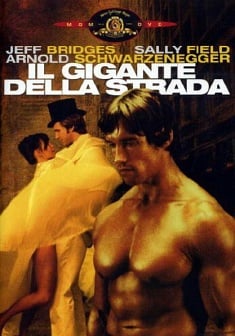Appena due anni prima, nel 1953, Michelangelo Antonioni aveva composto il suo film a episodi “I vinti” ispirandosi a fatti di cronaca, un film rigorosamente specchio della realtà nell’intenzione dell’autore, ma poco apprezzato da pubblico e critica che solitamente amano essere solleticati con prodotti più accattivanti; là Antonioni parlava di “generazione bruciata” ed era un concetto che girava nell’aria se due anni dopo, appunto, i distributori italiani intitolarono “Gioventù bruciata” il film che nell’originale è “Rebel Without a Cause” il cui titolo rimanda al libro che lo psichiatra Robert Lidner aveva pubblicato nel ’44, “Ribelle senza causa: analisi di uno psicopatico criminale” in cui studiava lo psicopatico come qualcuno “incapace di compiere sforzi per il bene altrui”, non empatico diremmo oggi, riferendosi al caso reale di un ragazzo di nome Harold allora detenuto in Pennsylvania. La Warner Bros. aveva subito acquisito i diritti per svilupparne un film che nel corso degli anni e delle riscritture aveva alla fine una narrazione che più nulla conservava del libro se non il titolo, e il progetto finì momentaneamente in un cassetto. Ma l’argomento “giovani ribelli” era nell’aria e furono messi in cantiere vari progetti fra cui spiccarono in quella prima metà degli anni ’50 “Il selvaggio” con Marlon Brando diretto dall’ungherese László Benedek e “Il seme della violenza” con Glenn Ford diretto da Richard Brooks. Così Nicholas Ray, attento agli umori del botteghino, rispolverò il suo soggetto la cui sceneggiatura conclusiva la firmò Stewart Stern qui alla sua prima prova importante: era amico di James Dean e in qualche modo veicolò la sua scrittura attorno alla figura del giovane attore emergente, chiamando James-Jimmy il suo personaggio. Stern due anni dopo l’improvvisa morte di Dean scrisse il documentario “La storia di James Dean” diretto da un giovane Robert Altman già sceneggiatore per la tv ma non ancora regista cinematografico.

Il film di Ray si distingue dagli altri perché per la prima volta esamina il contesto dei giovani ribelli non più come espressione delle classi disagiate ma anche all’interno dell’alta borghesia, un contesto in cui gli adulti erano colpevoli quanto e forse più dei ragazzi. Con la scrittura di Stern si definirono le influenze chiavi del film: Ray auspicava un tono classico e senza tempo per la sua storia, guardando a “Romeo e Giulietta”: “la migliore commedia scritta su giovani delinquenti” aveva detto, mentre lo sceneggiatore dal canto suo considerava il film una rilettura di Peter Pan; di fatto entrambi hanno attinto alle proprie vite, e Stern in particolare prese ispirazione dal rapporto conflittuale con i suoi genitori: “Ray aveva terribili rimorsi di coscienza su sé stesso come padre, e io ero terribilmente furioso con me stesso come figlio” ha ricordato lo sceneggiatore. Il resto del cast: Edward Platt è il poliziotto assai comprensivo, Jim Backus, Ann Doran e la veterana Virginia Bissac sono i genitori e la nonna del protagonista; William Hopper e Rochelle Hudson sono i genitori della ragazza; Marietta Candy è la mamie, e Corey Allen è il capo dei “bravacci” che sfida il protagonista nella corsa mortale; nel gruppo debutta Dennis Hopper.
Mentre il film era in scrittura, nel 1947 venne convocato negli studios il 23enne Marlon Brando, già giovane ribelle emergente nelle produzioni teatrali, a cui furono date alcune pagine di una sceneggiatura incompleta per sostenere un provino col regista, al quale bastarono solo cinque minuti per decidere che il ruolo sarebbe andato a lui, facendolo debuttare sul grande schermo; senonché, non essendoci ancora una vera sceneggiatura completa da valutare, il giovanotto che aveva già le idee molto chiare preferì continuare a fare teatro e quell’anno trionfò in “Un tram che si chiama Desiderio” di Tennessee Williams, dramma che avrebbe poi recitato al cinema nel suo secondo film del 1951: aveva debuttato l’anno prima con “Il mio corpo ti appartiene” di Fred Zinneman. Per gli appassionati di Brando quel provino è inserito in un’edizione speciale del DVD del 2006 di “A Streetcar Named Desire”. Quando nel 1950 fu conclusa la sceneggiatura definitiva Marlon Brando era ormai irraggiungibile, oltre a essere fuori parte per ragioni anagrafiche dato che aveva 31 anni e il personaggio ne aveva 16, e produzione e regista appuntarono la loro attenzione sul 24enne James Dean già star con “La valle dell’Eden” di Elia Kazan.
La vera 17enne Natalie Wood (all’anagrafe Natal’ja Nikolaevna Zacharenko, figlia di immigrati ucraini) era all’epoca un’ex attrice bambina che con questo film rilanciò la sua carriera come adulta, benché avesse seriamente rischiato di non ottenere la parte perché secondo il regista aveva l’aria da brava ragazza per niente ribelle e, come ella stessa raccontò nella sua autobiografia, solo quando finì in ospedale per un incidente d’auto dopo una serata con gli amici e Nicholas Ray andò a trovarla – e c’è molto di romanzato a mio avviso in questo racconto: il dottore l’aveva apostrofata “dannata delinquente giovanile” e lei urlò subito al regista: “Hai sentito come mi ha chiamato, Nick?! Mi ha chiamato un dannata delinquente giovanile! Ora me la dai la parte?!”
Il 16enne Sal Mineo, figlio di immigrati siciliani (il padre Salvatore senior era un costruttore di bare) aveva debuttato lo stesso anno in “La rapina del secolo” interpretando Tony Curtis da ragazzo; anche sua sorella Sarina e i fratelli Michael e Victor erano stati avviati al palcoscenico dalla madre che evidentemente covava sogni artistici, e il ragazzino si era fatto notare nelle messa in scena del 1951 di “La rosa tatuata” di Tennessee Williams, dramma che l’autore aveva scritto per la nostra Anna Magnani che però declinò l’offerta perché non riteneva il suoi inglese abbastanza buono da potersi esibire in teatro, e avrebbe recitato il personaggio nel film di quattro anni dopo diretto da Daniel Mann; Sal continuò in teatro come principino nel musical “Il Re ed Io”, libretto di Oscar Hammerstein II e musiche di Richard Rodgers, con Yul Brinner nel ruolo del protagonista che avrebbe ripreso nel film diretto da Walter Lang nel 1956.


Il film, venduto come un torbido dramma generazionale, riscosse grande successo in patria e all’estero, ma in realtà è un gran pasticcio pieno di superficialità e retorica che sfiorano il ridicolo, nonché di madornali errori. Comincia presentando i tre giovani ribelli che si incontrano a un posto di polizia: James Dean, fermato per ubriachezza molesta, rivela un tormentato rapporto con la famiglia ultra borghese, ma poi a casa si attacca un paio di volte alla bottiglia del latte, espediente narrativo per far capire al pubblico che in fondo è un bravo ragazzo; Natalie Wood, fermata perché coinvolta in una rissa dei suoi amici definiti dal doppiaggio italiano “bravacci” con memoria leopardiana, perché i bulli e il bullismo sono di là da venire; anche la ragazza è in piena crisi generazionale: essendo divenuta adolescente non è più la cocca di papà del quale cerca ancora imbarazzanti baci e abbracci, e il pover’uomo fatica a staccarsela di dosso per non sembrare un maniaco; Sal Mineo è stato abbandonato da entrambi i genitori alle cure della mamie negra e poverino fa il ribelle sparando agli animaletti. Psicologia da strapazzo e caratteri sbozzati con l’accetta, e la critica non fu tutta benevola: il film, altrove lodatissimo, fu tacciato di superficialità e rozzezza espressiva, i personaggi e le situazioni quasi da cartone animato, mentre di James Dean si arrivò a dire che aveva copiato lo stile recitativo di Marlon Brando con una malignità che pescava nei retroscena della vita segreta dei due…
Mineo ha un ruolo fortemente ambiguo: il suo personaggio si lega a quello del protagonista, spinto a parole da una forte ammirazione prossima all’idolatria, ma nei fatti sembra spinto da una forte attrazione omoerotica e Nicholas Ray preme il pedale in questo senso e in molte inquadrature, come del resto in tutta la sceneggiatura, il ragazzino è sempre lì a fare da terzo incomodo fra James Dean e Natalie Wood, quasi un ménage à trois.
In un’intervista del 1972, quattro anni prima della sua tragica morte, l’attore – che aveva già dichiarato la sua bisessualità (come compromesso per non dichiararsi pienamente omo) in un’epoca ancora fortemente omofoba – spiega che quel suo personaggio “è stato, in un certo senso, il primo adolescente gay nei film. Lo guardi ora, sai che aveva una cotta per James Dean. Lo guardi ora, e tutti sanno della bisessualità di Jimmy, quindi è come se lui avesse avuto una cotta per Natalie e me. Ergo, io dovevo essere fatto fuori”. Fu tristemente profeta: aveva 37 anni e stava interpretando in teatro il ruolo di un ladro omosessuale in “P.S. Your Cat Is Dead!” spettacolo che da San Francisco si stava spostando a Los Angeles: fu accoltellato al cuore mentre rientrava a casa dalla prova generale; l’immediata supposizione fu quella di un reato omofobo ma venne arrestato un fattorino di pizze a domicilio colpevole di diversi rapine nella zona il quale dichiarò di non sapere chi fosse la vittima; ma Mineo non era stato derubato quindi di suppose ancora che il delitto fosse maturato nell’ambiente della droga di cui l’attore era consumatore abituale; in ogni caso il movente restò insoluto.
Il film fu censurato nel Regno Unito e addirittura bandito in Nuova Zelanda, e Spagna dove poi uscì nel 1964. Ricevette tre nomination agli Oscar del 1956: miglior soggetto a Nicholas Ray e migliori non protagonisti Sal Mineo e Natalie Wood che però si aggiudicò il Golden Globe, mentre quell’anno James Dean ebbe una candidatura postuma – la prima nella storia degli Oscar – nella sezione protagonisti per il precedente dello stesso anno “La valle dell’Eden”. Nomination ai britannici BAFTA per il miglior film e il protagonista. Con tutte le sue imperfezioni il film è stato inserito fra i 100 migliori americani ed è diventato un cult grazie anche alla sua fama di film maledetto per la tragica fine dei suoi tre protagonisti: di Mineo ho detto; e come si sa Dean era morto in un incidente sulla sua Porsche 550 Spyder “Little Bastard” mentre finiva di girare il suo ultimo film “Il gigante” che uscì postumo, e anche quando uscì “Gioventù bruciata” nell’ottobre del ’55, Jimmy era già morto da un mese.
Natalie Wood morì 43enne in un incidente nautico che tutt’oggi rimane misterioso: all’epoca l’autopsia rivelò che l’attrice era morta annegata cadendo dal gommone del suo yacht, e nel suo sangue furono ritrovate importanti tracce di alcol e psicofarmaci; la sera prima aveva litigato col marito Robert Wagner perché lei flirtava col collega Christopher Walken, ospite sull’imbarcazione, col quale lei stava girando il fantascientifico “Brainstorm” diretto da Douglas Trumbull e uscito postumo; diverse circostanze e dettagli fecero pensare che si trattasse di uxoricidio passionale, e le indagini sono state riaperte un paio di volte in anni più recenti però senza mai giungere a ulteriori risultati specifici. Nel 2004 Peter Bogdanovich diresse la miniserie TV “Il mistero di Natalie Wood”.
Appena finite le riprese del film Dean, Mineo e il debuttante Dennis Hopper saranno di nuovo scritturati per “Il gigante”. Hopper, benché in ruoli secondari si fece notare come ribelle e come tale continuò per qualche anno, passando per la factory di Andy Warhol e partecipando a un suo filmetto sperimentale, prima di posare per una delle sue opere photo-pop. Hopper aveva davvero un animo da ribelle, da ribelle secondo la borghesissima morale dell’epoca, e per il breve periodo hippie che percorse gli anni ’60 ne fu esponente, prima di debuttare in regia con “Easy Rider” nel 1969 in cui esprime proprio quella cultura, controcorrente e assolutamente pacifista.
E ora le chiacchiere e i pettegolezzi. Nel 2016 è stato pubblicato il libro, scandalistico sin dallo stile della copertina, “James Dean: Tomorrow Never Come”, scritto da Darwin Porter e Danforth Prince, entrambi abitualmente scrittori di libri e guide per viaggiatori che qui pare abbiano tentato il salto “Hot, Unauthorized, and Unapologetic!” nel mondo delle biografie più o meno bollenti, non autorizzate e men che meno apologetiche. Nel libro parla a ruota libera un vecchio amico di Dean, Stanley Haggart, altro autore di libri di viaggi e vacanze, che ha riferito che Jimmy Dean aveva incontrato per la prima volta il suo idolo Marlon Brando allorché quello era andato a New York perché curioso di sentirlo durante un incontro col pubblico e la stampa. I due si incrociarono per pochi istanti, sufficienti perché Jimmy dichiarasse a Marlon la sua grande ammirazione e anche il suo amore, e gratificato da tanta attenzione Marlon rispose baciandolo sulla bocca: fu l’inizio di una relazione bollente dai risvolti sadomaso col più anziano e macho che si divertiva a manipolare e umiliare il più giovane e fragile, usandolo come oggetto sessuale, e pare anche che gli spegnesse addosso le cicche di sigarette, e più Jimmy gli mostrava di aver perso completamente la testa, più Marlon lo umiliava in un cortocircuito di omofobia all’interno di un rapporto omosessuale. “Avevo l’impressione che Jimmy avesse una relazione da gatto e topo con Brando, Brando era il gatto, ovviamente. Sembrava giocare con Jimmy per divertimento, lo usava sadicamente e Jimmy lo seguiva come un cane, con la lingua fuori” ha rivelato Haggart che ha aggiunto che Brando costringeva Dean a fare da spettatore passivo mentre lui se la spassava con altri, oppure lo lasciava “come un cucciolo di cane” ad aspettare fuori dalla porta che lui si decidesse a farlo entrare. Marlon amava solo sé stesso: “Mi comandava sempre mentre facevamo l’amore” confessava Jimmy agli amici. Nel libro parla anche il compositore Alec Wilder che fu amico di entrambi gli attori: “Erano sicuramente una coppia. Ma si potrebbe dire che la ‘fedeltà sessuale’ non facesse parte del loro vocabolario”. In età matura Brando ha dichiarato: “Come un gran numero di uomini, ho avuto esperienze gay e non me ne vergogno. Non ho mai prestato molta attenzione a ciò che la gente pensa di me”.

La stella di James Dean brillò con tre soli film in un solo anno e la sua morte tragica e improvvisa contribuì a creare il suo mito fra i giovani, e anche fra i meno giovani, che all’epoca non volevano sentir parlare di omosessualità. Jonathan Gilmore, ex attore bambino diventato giornalista scandalistico, fu il primo a parlare pubblicamente dell’omosessualità di Jimmy nel suo libro “The Real James Dean” ma nessuno gli credette e anzi fu etichettato come uno sporco profanatore di tombe. La giovane sfortunata star ebbe un solo amore femminile: l’italiana Anna Maria Pierangeli, adottata a Hollywood come Pier Angeli, la quale aveva avuto un affaire sentimentale col collega Kirk Douglas incontrato sul set dell’episodio “Equilibrio” nel film a episodi “Storia di tre amori”.
I due, disadattati ognuno a suo modo, si incontrarono nell’estate del 1954 mentre lei stava girando “Il calice d’argento” nel set della Warner accanto a quello dove lui girava “La valle dell’Eden”. Elia Kazan, regista di lui, dichiarò in un’autobiografia di averli sentiti fare l’amore nel camerino di lui. Lei, emigrata a Hollywood, non si era ancora del tutto integrata; lui era di suo fragile e disadattato, in cerca di un amore assoluto che sapesse accoglierlo con tutte le sue imperfezioni: “Sono un essere malvagio, altrimenti mia madre non sarebbe morta (era morta di cancro all’utero quando lui aveva 9 anni e il padre lo aveva mandato a vivere presso parenti) e mio padre non m’avrebbe abbandonato” aveva confessato a un sacerdote che poi, tanto per cambiare, si era approfittato sessualmente di lui. Jimmy e Pier si intesero subito, e subito lui avrebbe voluto sposarla. Ma la madre di lei, cattolicissima, si oppose perché lui era di famiglia quacchera, oltre a tutte le altre chiacchiere di corridoio; la rigidissima signora, che metteva bocca su tutto nella vita della figlia, avrebbe voluto invece accasarla col macho Marlon Brando, ignorando le intime digressioni del divo. Come fu, come non fu, alcuni mesi dopo lei sposò il cantant’attore italo-americano Vic Damone, e la rottura improvvisa che seguì all’improvviso matrimonio, contribuirono ad acuire il senso di auto distruzione dell’attore, che finì come finì: fra i documenti personali trovati nel cruscotto dell’auto c’era un foglio con la formula matrimoniale e sopra, scritto a penna, il nome di Anna Maria Pierangeli. Alla morte di lui, lei cadde in una profonda depressione tanto che fu ricoverata in una clinica in Italia e per lei seguì una vita sentimentale fatta di fallimenti, così come la carriera andò via via in discesa. Morì suicida a 39 anni per overdose da psicofarmaci, quindici anni dopo la morte di lui. Subito dopo la sua morte venne ritrovata una sua lettera destinata a James Dean che si concludeva: “A te, mio unico, grande amore”.
Oggi diventa illuminante ciò che Jimmy aveva detto di sé: “Essere un attore è la cosa più solitaria del mondo. Sei completamente da solo con la tua concentrazione e con la tua immaginazione, e quello è tutto ciò che hai… Credo ci sia una sola forma di grandezza per l’uomo. Se un uomo può colmare il vuoto tra la vita e la morte. Voglio dire, se riesce a vivere anche dopo che è morto, allora forse quello era un grand’uomo. Per me l’unico successo, l’unica grandezza, è l’immortalità”.

La Porsche 550 Spyder sulla quale Dean perse la vita fu prodotta fra il 1953 e il 1957, e fu proprio lui a soprannominarla affettuosamente “Little Bastard” per le sue performance. Inizialmente fu impiegata dalla Porsche nelle corse professionali come Le Mans e poi con alcune modifiche fu proposta agli acquirenti privati, quei ragazzacci come James Dean o Steve McQueen in cerca del brivido delle corse più o meno legali su strada. La Warner Bros. aveva espressamente vietato all’attore sotto contratto, che amava anche scorrazzare in moto, di fare corse: aveva appena finito di girare “Gioventù bruciata” era già impegnato sul set di “Il gigante” – ma Dean disattese il divieto. George Barris, il suo meccanico, si incaricò di recuperare la vettura gravemente danneggiata e mentre veniva caricata su un rimorchio un sostegno si spezzò e finì per fratturare l’anca e una gamba a un meccanico: comincia lì la sinistra ma affascinante fama di auto maledetta intorno alla quale sorsero chiacchiere e leggende, ma alcuni fatti sono reali, riportati dalla stampa con tanto di nomi e cognomi. Barris aveva tenuto in garage telaio e carrozzeria rivendendo alcuni pezzi. Il motore venne acquistato da un altro di quei piloti dilettanti in cerca di fama ed emozioni, e ne ebbe a sufficienza quando durante una gara perse il controllo dell’auto e finì per travolgere e uccidere un commissario tecnico e ferire un medico. Un altro pilota dilettante montò un semiasse della Little Bastard e finì coinvolto in un gravissimo incidente; un altro ancora, che acquistò gli pneumatici rischiò di perdere la vita. Pare che addirittura un ragazzino avesse tentato di rubare un pezzo dell’auto dal garage di Barris ma col telaio si tagliò un braccio in modo così da grave da dover essere amputato, storia non documentata dai giornali quest’ultima, ma le vere storie raccapriccianti continuarono: la “bastardina” fu utilizzata per una campagna itinerante di sensibilizzazione contro la velocità: pagando un biglietto si poteva salire sull’auto accartocciata, dove un cartello con la scritta “questo incidente poteva essere evitato” fungeva da ulteriore scoraggiamento; ma giunta a Sacramento, il telaio dell’auto cedette e fracassò l’anca di un visitatore. Poi, durante la trasferta verso la tappa successiva, il camion che la trasportava venne tamponato, i portelloni si aprirono e la Porsche scivolò fuori uccidendo un uomo a bordo di un’altra auto. Ma non finisce qui: giunta a New Orleans, in seguito alla rottura della pedana di sostegno l’auto si spaccò in undici pezzi: ce n’era abbastanza e terrorizzati gli addetti ai lavori decisero di rispedire i rottami a Los Angeles tramite un mezzo più sicuro: il treno. E la macabra storia si conclude con un mistero: l’auto scomparve nel nulla durante il viaggio e non fu mai più ritrovata. Vennero anche ingaggiati degli investigatori privati e addirittura fu messa una taglia di un milione di dollari che molti cercarono di incassare con delle imitazioni, ma ancora oggi dove sia finita la Little Bastard rimane un mistero. Un mito macabro all’interno di un mito romantico.