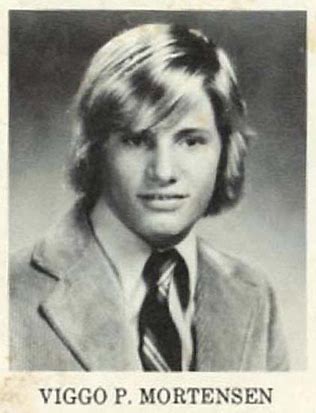Fiat lux, e luce fu. Dio creò l’Universo e molto tempo dopo le sue Creature intrappolarono la Luce nella fotografia, qualcuno anche sognando di vedervi impresso il volto del Dio e invece è andata a finire che non facciamo altro che replicare i nostri volti selfie su selfie: dio siamo noi. Lasciando le cose divine a chi se ne intende, fingiamo qui di intenderci di fotografia e cinema: entrambi alla loro creazione sono stati considerati principalmente strumenti legati a un discorso antropologico e ambientale, geografico e umano, in quanto inquadravano e catturavano la società e l’ambiente così com’erano: senza raccontarli ancora, ovvero senza rappresentarli, senza la fiction per dirla con parole odierne: erano documenti, documentari; la rappresentazione in quanto tale avveniva dopo, negli spazi in cui la fotografia e il cinema venivano presentati al pubblico, spazi dapprima ambulanti in cui erano utilizzati tendoni in stile circense, quando non addirittura all’aperto nelle serate estive, o adattando locali preesistenti sul territorio della tournée; ovviamente l’arrivo del fenomeno era annunciato preventivamente da manifesti affissi sui muri.
Tutti sappiamo che il cinema è nato in Francia con i Fratelli Lumière, ma non tutti sappiamo che fra i loro collaboratori ci furono due italiani, due amici piemontesi ingaggiati come rappresentanti in Italia: il torinese Vittorio Calcina che oggi viene ricordato come il primo cineasta italiano, che sul finire dell’Ottocento fu autore della prima ripresa cinematografica di un papa allorché immortalò Leone XIII nei Giardini Vaticani: non immortaliamo il volto del dio ma possiamo con i suoi rappresentanti in terra. L’altro italiano fu il cuneese Giuseppe Filippi che viene ricordato come fra i primi operatori-proiezionisti. Con questi due precedenti è facile immaginare come una fra le prime case di produzione cinematografica venisse fondata a Torino, città che negli anni successivi divenne una delle capitali del cinema. Un po’ scienza e un po’ tecnica l’impresa era nuova e poiché prospettava lauti guadagni ci furono dei coraggiosi pionieri che posero l’Italia fra le nazioni all’avanguardia nelle produzioni cinematografiche.




Ci fu anche Arturo Ambrosio, che da anonimo impiegato torinese presso una ditta di tessuti, seguì la sua bruciante passione per quel nuovo fenomeno che era la fotografia, e già trentenne (all’epoca era un’età rispettabile e ci si augurava che si fosse rispettabilmente già sistemati) lasciò il lavoro per andare a Losanna a studiare la sua passione, e appresi i fondamenti tornò nella sua Torino per aprire un negozio di articoli ottici e fotografici; ma la fotografia si stava trasformando in cinema e la sua passione si accese di quelle nuove prospettive, così decise di rimettersi in viaggio e spese un altro anno fra Francia Inghilterra e Germania continuando il suo preziosissimo apprendistato, alla conclusione del quale si ristabilì nella sua città per fondare la Ambrosio Film dotata di un proprio stabilimento, per la quale si improvvisò necessariamente anche regista, facendosi affiancare da altri amici con la medesima passione, e tutti insieme facevano di tutto un po’ essendo le professionalità specifiche ancora in divenire: sceneggiatori, operatori di ripresa, direttori della fotografia, direttori artistici e all’occorrenza anche attori: erano i tecnici Roberto Omegna e Giovanni Vitrotti e l’attore di filodrammatica Luigi Maggi, tutti ricordati oggi come pionieri del cinema, che a partire dal 1904 cominciarono i loro esperimenti cinematografici di documentari sportivi e di comiche.



È curioso ricordare come per le loro primissime produzioni, fra le quali si annovera già il documentario “Briganti di Sardegna”, si fossero poi spostati anche in Sicilia realizzando vari titoli: “Una zolfara” “Una gita a Monreale” “Sicilia illustrata” “Marsala” che si inquadrano proprio nell’ottica del cinema come documento ambientale e curiosità antropologiche: l’unità dell’Italia era una cosa di appena cinquant’anni prima e Piemonte e Sicilia erano ancora due mondi lontanissimi. La prima grande produzione della Ambrosio fu lo storico “Gli ultimi giorni di Pompei” del 1908, un vero e proprio kolossal dell’epoca, ovviamente muto, regia firmata da Ambrosio e Maggi ma con riprese dirette da Omegna, in pratica direzione artistica e direzione tecnica disgiunte. Nel 1911 Ambrosio fu invitato dallo Zar Nicola II Romanov a creare in Russia un’industria cinematografica, e l’anno successivo si assicurò i diritti esclusivi per filmare le opere di Gabriele D’Annunzio; viene inoltre ricordato negli Stati Uniti per essere stato capace con i suoi film epici di rivaleggiare con l’industria hollywoodiana, che in realtà all’epoca era ancora molto disorganizzata. In questo link quel primo kolossal pubblicato su Wikipedia.
A seguire, nel 1905 viene fondata a Roma la Società Primo Stabilimento Italiano di Manifattura Cinematografica Alberini e Santoni, dotata di un teatro di posa sulla via Appia non lontano da Porta San Giovanni – oggi praticamente in centro. Realizzò il primo film a soggetto proiettato in pubblico, “La presa di Roma” poi noto anche come “Bandiera bianca” e “La breccia di Porta Pia” che i romani potettero vedere su un tendone piazzato proprio davanti a Porta Pia nell’anniversario del fatto, il 20 settembre 1905, ma si sa di una precedente proiezione a Livorno; in questo link la pagina Wikipedia su cui è caricato il filmato di sei minuti superstite dei circa dieci del film. Quella Società fu nel giro di un anno rilevata dal barone piemontese (ancora il Piemonte in prima fila) Alberto Fassini che la trasformò nella più nota (a posteriori) Società Italiana Cines che si specializzò in produzione storiche come “Garibaldi” e in costume come “Otello” e “Il fornaretto di Venezia”.
Altra importante casa di produzione dell’epoca fu la Itala Film, sempre a Torino, che nasce dalle ceneri di una precedente avanguardistica impresa specializzata nello sfruttamento commerciale della comunicazione senza fili, ma era ancora troppo presto e la società cambiò in corsa la propria attività; restando nell’ambito delle novità si trasformò in manifattura cinematografica nel 1907 come Carlo Rossi & C. i cui soci impresari erano il chimico Carlo Rossi e l’industriale di origine tedesca Guglielmo Remmert, che non sapendo dove mettere le mani assunsero personale francese proveniente dalla Pathé, e cominciarono così bene che i loro film vennero anche distribuiti negli Stati Uniti.
Ma appena otto mesi dopo la proficua società fu messa in liquidazione per gli insanabili contrasti sorti fra i due soci, e il genero di Remmert, Carlo Sciamengo, rilevò la società insieme a un giovane contabile (anche diplomato in violino al Conservatorio di Torino) che avrebbe inscritto il suo nome fra i grandi del cinema muto, Giovanni Pastrone, e insieme fondarono la Itala Film che ben presto si accreditò come la terza più importante casa di produzioni cinematografiche per il numero delle pellicole o delle filme (così si dicevano all’epoca) vendute.
Fra le grandi produzioni dell’Itala il più grande e clamoroso successo fu “Cabiria” diretto da Pastrone, che con le sue tre ore e dieci fu il primo vero kolossal italiano di lunga durata e anche il più esageratamente costoso: a fronte di un costo medio di cinquantamila lire, il film costò un milione di lire-oro, termine che comprendeva sia la moneta coniata in oro che quella convertibile in base al rapporto di parità aurea stabilito nel 1862 all’avvenuta unità d’Italia; convertibilità in oro che però fu subito sospesa nel 1866 a causa dei costi della Terza Guerra d’Indipendenza del Regno d’Italia contro l’Impero Austriaco; la convertibilità fu ripristinata nel 1881 ma ormai la degenerazione delle monete in metallo vile e ancor più vile carta stampata era avviata, senza gravi conseguenze per la vita di tutti i giorni della gente comune, e la convertibilità in oro fu di nuovo messa in discussione nel 1887 e, senza dichiararlo apertamente, fu di nuovo sospesa: la reale copertura aurea del denaro in circolazione era ormai solo al 40% del totale e la convertibilità veniva garantita solo a imprese importanti, come appunto la produzione di “Cabiria”, scritto dallo stesso Pastrone con gli intertitoli (i cartelli) di Gabriele D’Annunzio su soggetto dello stesso D’Annunzio dagli scritti di Tito Livio, Gustave Flaubert ed Emilio Salgari. Cabiria, che significa “nata dal fuoco” è un nome inventato dal D’Annunzio grande inventore di nomi (sua invenzione anche Ornella e suo anche “La Rinascente”). Il film restò per sei mesi in cartellone a Parigi e addirittura per un anno a New York, dove David W. Griffith rimase colpito dalla spettacolarità delle riprese, non più statiche, e soprattutto dalla durata: presto avrebbe realizzato il suo lungometraggio “Nascita di una Nazione” che in qualche modo segna anche la nascita di quella nazione come centro di produzioni cinematografiche.
Ma anche a Napoli c’era un gran fermento. Il 19enne di buona famiglia Gustavo Lombardo abbandonò gli studi di giurisprudenza, facendo arrabbiare il papà, per seguire la sua passione fondando nel 1904 una sua società per la distribuzione di pellicole, diventando rappresentante per l’Italia meridionale delle case del nord e di quelle francesi. E solo nel 1916 si buttò nella produzione creando la Teatro-Lombardo Film che successivamente trasformò in Lombardo Film assorbendo la conterranea Polifilms in crisi economica e accreditandosi fra i più importanti produttori italiani, fino a dare vita nel 1928 alla Titanus, ancora oggi attiva come distributore e produzione tv.
Ed è ancora napoletano il primo regista a firmare il primo cortometraggio italiano: fu Roberto Troncone, giovane laureato in giurisprudenza che appassionatosi al cinema si procurò una macchina da presa Lumière girando già nel 1903, prima ancora dei primi esperimenti torinesi, il documentario “Il ritorno delle carrozze da Montevergine”; nel 1906, aggiornatosi con una nuova macchina da presa Gaumont, il pioniere napoletano gira con riprese “dal vero” mentre il Vesuvio stava eccezionalmente eruttando il 6 aprile, filmando dal treno della Circumvesuviana; il cortometraggio, intitolato “Eruzione del Vesuvio” gli varrà fama internazionale, e creò la Fratelli Troncone & C. che fu la prima vera casa di produzione napoletana, che nel 1909 trasformò in Partenope Film che visse fino al 1926, anno in cui chiuse a causa del clamoroso insuccesso commerciale di “Fenesta ca lucive” che era il remake di un successo di undici anni prima. Già allora bisognava andare cauti coi remake!

A Milano c’era il fotografo Luca Comerio “Fotografo Personale di Sua Maestà il Re” attività, questa, che era nata da un fortunato scatto di Umberto I mentre conversava con il vescovo della città e che gli valse i complimenti del Savoia; ma oltre che rinomato ritrattista che stampava anche su porcellana fu anche precursore del foto-giornalismo per avere documentato i moti di Milano del 1898 sanguinosamente repressi dal generale Bava Beccaris, episodio che ispirò la vendetta dell’anarchico Gaetano Bresci che nel 1900 sparò tre colpi di rivoltella uccidendo il re Umberto. Intanto, in quell’ancora tranquillo fine ‘800, Comerio pensò di ampliare la sua attività realizzando dei brevi filmati con l’attore trasformista Leopoldo Fregoli, il quale aveva già cominciato a sperimentare il cinema con i Fratelli Lumière e con Georges Méliès. Nel 1907 Comerio vinse 500 lire a un concorso fotografico e andò a Parigi per acquistare un cinepresa Pathé con la quale, grazie alla stima che si era conquistata presso i Savoia, gli fu concesso di imbarcarsi sul panfilo reale Trinacria per documentare la crociera nel Mediterraneo del nuovo re Vittorio Emanuele III: fu quel servizio che gli valse la nomina a fotografo ufficiale della Real Casa. Quindi costituì la Luca Comerio & C., la prima manifattura cinematografica milanese, cominciando a realizzare reportage d’attualità di stampo giornalistico, prima di darsi alle fiction; come fotoreporter documentò anche il terribile terremoto di Messina del 1908 e nel 1911 partecipò come fotografo e cineoperatore alla spedizione militare in Libia: fu probabilmente il primo a fare un reportage di guerra, addirittura in Kinemacolor, e poi fu in campo anche durante la Prima Guerra Mondiale. Nel frattempo, attraverso varie trasformazioni societarie, Comerio aveva fondato nel 1909 la Milano Films con ampia partecipazione di ben 24 soci finanziatori del bel mondo milanese: un nuovo assetto societario dal quale Comerio prese presto le distanze per divergenze artistiche e organizzative.


FINE PRIMA PARTE, QUI LA SECONDA